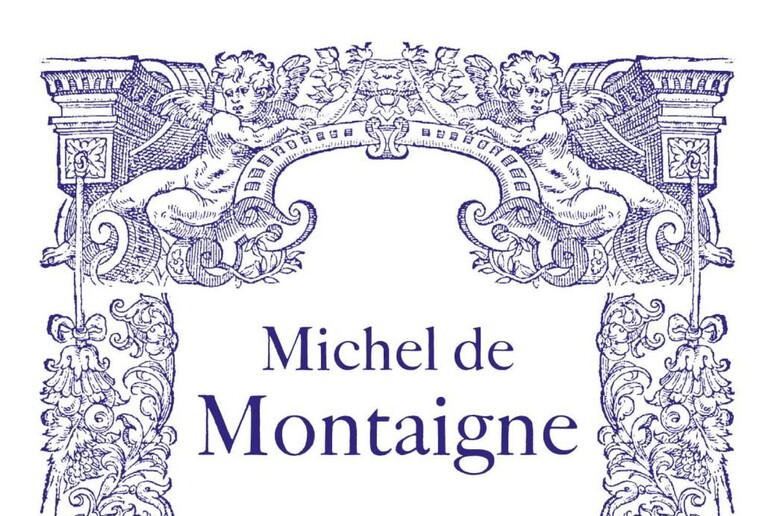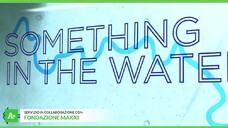(di Paolo Petroni)
MICHEL DE MONTAIGNE,''FILOSOFIA COME
ARTE DI VIVERE'' (FAZI, pp. 258 - 15,00 euro - Traduzione di
Federico Ferraguto) - ANTOINE COMPAGNON, ''UN'ESTATE CON
MONTAIGNE'' (ADELPHI, pp. 136 - 12,00 euro - Traduzione di
Giuseppe Grimonti Greco)
Un letterato e poeta fine come Franco Marcoaldi dice di non
avere dubbi sul fatto di trascorrere gli ultimi giorni
dell'anno, giorni di bilancio, riflessioni e conti con se
stessi, con un libro e un autore precisi, Michel de Montaigne e
i suoi ''Essais'' (Saggi), brevi scritti dai titoli più vari:
''Della tristezza'', ''Dei bugiardi'', ''Dell'età'', ''Della
coscienza'', ''Del pentirsi'', ma anche ''Come l'anima riversi
le sue passioni su oggetti falsi quando i veri le vengono a
mancare'' o ''Se il comandante di una piazzaforte assediata
debba uscire per parlamentare''.
Tutto preceduto da una nota introduttiva in cui si precisa:
''Questo, o lettore, è un libro sincero ... Voglio che mi si
veda qui nel mio modo d'essere semplice, naturale quotidiano,
senza né affettazione né artificio'', concludendo ''così,
lettore, sono io stesso la materia del mio libro e non c'è
ragione che tu spenda il tuo tempo su un argomento tanto frivolo
e vano''. Tanto che è proprio questa consueta introspettiva
intimità in cui finiamo per ritrovarci anche noi con semplicità
e senza infingimenti, scoprendo perché in uno dei pensieri
finali, in cui si legge: ''Tutta la filosofia morale si applica
benissimo a una vita comune privata, come a vite di più ricca
sostanza: ogni uomo porta in sé la forma intera della condizione
umana''.
Non si può così non concordare con Marcoaldi a proposito di
questi scritti pubblicati tra il 1580 e il 1595, circa 450 anni
fa, eppure così moderni, forse addirittura che risuonano in
maniera più diretta e coinvolgente con noi oggi di quando furono
scritti, nella torre biblioteca in cui Montaigne si ritirò a
leggere i classici e scrivere a 38 anni, dopo una vita impegnata
e con incarichi pubblici. Così le sue pagine non sono solo
frutto di un pensiero contemplativo e introspettivo ma anche di
uno sociale e politico, nato in un periodo di transizione e
cambiamenti profondi, in cui il nostro tempo può ritrovarsi. E
poi c'è lo stile, privo di retorica strumentale e di artifici
dialettici per cercar di convincere, ma un riferire, raccontare,
argomentare, divagare in libertà e semplicità, che non vuol dire
superficialità o facilità, ma verità intima e personale che
diviene naturalmente universale e con cui ci è naturale
confrontarci. I suoi sono temi senza tempo, come l'amore,
l'amicizia, la vanità, la bellezza e, particolarmente
interessanti in questi tempi di pandemia, la salute e la
malattia che per il nostro non hanno confini precisi ma sono
diversi momenti della vita e della natura umana. Montaigne in
ogni caso se la prende con i medici, che dice non sanno quello
che fanno, tranne i chirurghi che vanno alla radice del male e
la eliminano, senza perdersi in congetture.
Diciamo che Montaigne ''esagera'', come scrive Antoine
Compagnon, spiegando che ''all'epoca sua la medicina è rozza e
inaffidabile, così che c'erano ottime ragioni per diffidarne'',
specie visto che non sapeva proprio che fare per i suoi dolorosi
calcoli renali. Compagnon, docente alla Sorbona e al College de
France, ha scritto un piccolo, bel libro che può aiutarci a
entrare nel mondo e nelle riflessioni dei Saggi, ''Un'estate con
Montaigne'', che raccogli 40 brevi conversazioni radiofoniche
sugli stimoli del maestro su temi senza tempo che riguardano la
vita intima e civile di ognuno.
Esistono varie edizioni complete dei ''Saggi'' di Montaigne,
a cominciare da quella Bompiani a cura di Fausta Garavini e
André Tournon, ma oggi per un primo approccio c'è quella edita
Fazi a cura di Federico Ferraguto, che esce in vari volumi e
raccogliendo i Saggi su base tematica. L'ultimo uscito è
particolarmente adatto per le nostre intenzioni di fine e inizio
anno, ''Filosofia come arte di vivere'', cui vanno aggiunti gli
altri: ''Coltiva l'imperfezione'', ''La fame di Venere'',
''Sopravvivi all'amore'', ''Scopri il mondo'' e ''Costruisci te
stesso'', capaci di far mettere in discussione noi stessi e i
diversi aspetti del nostro esistere. Montaigne ci fa capire che
la costruzione di sé non può essere teorica. Non sono gli
insegnamenti o i ragionamenti a motivare le nostre azioni, ma è
l'esperienza che forma il nostro spirito allo stile di vita che
abbiamo scelto. Filosofare, perciò, non significa solo pensare
in termini astratti, ma elaborare l'esperienza, o disporla
dandole un ordine che riteniamo efficace. ''Vivere è il mio
mestiere e la mia arte - scrive Montaigne - Chi mi proibisce di
parlarne a partire da quello che sento, dall'esperienza e
dall'uso che ne faccio, dovrebbe chiedere a un architetto di
parlare degli edifici non secondo se stesso, ma secondo il suo
vicino, cioè secondo la scienza di un altro, non secondo la
sua''.
Per Compagnon, il pericolo con Montaigne è di cadere in una
lettura moralistica, superficiale, estrapolando pensieri in
forma di aforismi o frasi ad effetto, mentre quella che deve
prevalere è la ''dimensione interrogativa di questi scritti, che
è la più convincete e attuale. I libri dovrebbero renderci
perplessi, farci dubitare e non fornirci risposte belle e
pronte'', insomma costringerci a pensare.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA