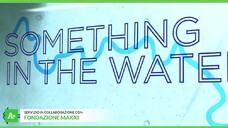(di Paolo Petroni)
In questa fine d'anno, negli ultimi
tempi difficili, pieni di disillusioni, di confronto con la
negatività dell'uomo e del mondo, tra crisi economiche e guerre,
non è strano che si sia tornati a parlare di melanconia, di quel
senso di vuoto e di impotenza, di tristezza e scoraggiamento in
cui ci si sente più soli, e, per guarirne, costretti a crescere,
a prendere coscienza e nuovo senso di vita, magari attraverso
un'azione-reazione creativa con la capacità di sentire come
propria la sofferenza degli altri, partecipando ai luttuosi e
tragici avvenimenti dei nostri giorni.
Al museo Mart di Rovereto (Tn) si è appena aperta la mostra
Mater et Melancholia dedicata a Durer, che presenta alcuni
capolavori dell'artista tedesco, dalla Madonna col Bambino detta
del Patrocinio a una serie di incisioni tra cui spicca
Melencolia I. Solo negli ultimi mesi è uscito il bel romanzo
Melancolia di Mircea Cartarescu (la Nave di Teseo, pp. 262 -
20,00 euro - Traduzione di Bruno Mazzoni), scrittore romeno dato
tra i favoriti all'ultimo Nobel per la letteratura, andato
invece al norvegese Jon Fosse, drammaturgo e autore di
Melancholia I e II (La Nave di Teseo, pp. 446 - 22,00 euro -
Traduzione di Cristina Falcinella) mentre dell'indagatrice
americana di certi malesseri e atteggiamenti odierni, Susan
Cain, è stato tradotto Il Dono della Malinconia (Einaudi, pp.
330 - 18,50 euro - Traduzione di Manuela Francescon). La Cain
parte da Aristotele, che notava come tutti i grandi filosofi,
artisti e poeti avessero inclinazione alla malinconia, e dallo
stato dolceamaro di Virgilio con la sua capacità di vedere "le
lacrime delle cose", entrandovi in sintonia, sentendosi empatici
con le anime che conoscono il dolore, arrivando così a parlare
dell'America d'oggi e a dedicare il suo libro a Leonard Cohen,
ricordandone l'invito: "Se hai un dolore di cui non riesci a
liberarti, fanne un'offerta creativa".
Anche la Melancholia di cui parla Fosse è in fondo creativa
se la indaga, insegue e scopre all'interno dei dipinti del
grande pittore norvegese ottocentesco Lars Hertervig di cui
percepisce una capacità "quasi spaventosa" di guardare al di là
dei confini angusti della razionalità, attraverso la sua
malattia, la sua solitudine. Lo scrittore, partendo dal suo
quadro intitolato 'Dall'isola di Borgoya', fa nascere dall'arte
la letteratura e la legittima, conducendoci all'interno della
visionaria follia dell'autore e le sue ossessioni amorose. Lo fa
basandosi totalmente sulla scrittura, giocando su costruzione,
sintassi e ritmi, ripetizioni e variazioni, con un'abilità che
accetta e riferisce i fatti biografici ma per immergersi negli
stati d'animo, creando un vortice di parole che risucchia a
fondo e ne riemerge, in cerca dell'assoluto. Così in una nota la
traduttrice si chiede: "Come tradurre chi dice l'indicibile?" e
risponde: scegliendo di "tendere l'orecchio in una audizione
fina e assorbire la musica originale per restituirla con
un'altra sonorità e altre regole armoniche". Diversa la
lettura più esistenziale e metaforica di Cartarescu con la sua
scrittura visionaria che, in tre racconti intimamente legati
gioca su immagini, sensazioni e pensieri che sono come momenti
di improvvisa comprensione dell'abbandono e le paure che si
legano alla crescita, al prendere coscienza del mondo. Ecco il
bambino che, uscita la madre, vive o immagina che questa non
torni più e lui affronti le difficoltà del vivere solo, poi i
due bambini che sotto le lenzuola si figurano conigli nella tana
in crudele lotta con la voracità delle volpi, sino al ragazzino
che scopre che per crescere bisogna periodicamente cambiare
pelle. Paure infantili di solitudini, dei pericoli della vita,
perché "è nell'infanzia che ha inizio la malancolia, quel
sentimento che ci accompagna tutta la vita, quella sensazione
che nessuno ci tenga più per mano", entrando soli
nell'adolescenza. Sentimento difficile da descrivere per lo
scrittore romeno, ma che trova verità poetica nelle sue pagine,
nel suo raccontare il fantastico nel modo più realistico,
amplificandone il senso intimo, la metafora.
Quanto a Albrecht Durer, la sua Melencolia I datata 1514,
senza dubbio la più conosciuta tra le sue incisioni, è
considerata la prima rappresentazione in cui il concetto di
malinconia fu trapiantato dal piano pseudo-scientifico al
livello dell'arte, della creatività e della bellezza, dandole un
senso che durò sino al Romanticismo. Una costruzione da sempre
oggetto di interpretazioni per via dei numerosi riferimenti
simbolici (la clessidra, la bilancia, il quadrato magico, il
compasso e il poliedro con due punte tronche), assieme alla
donna, forse una Musa in attesa dell'ispirazione, di un ritorno
della vitalità. Del resto fu Baudelaire a affermare poi di non
poter nemmeno immaginare bellezza che non comprendesse la
malinconia.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA