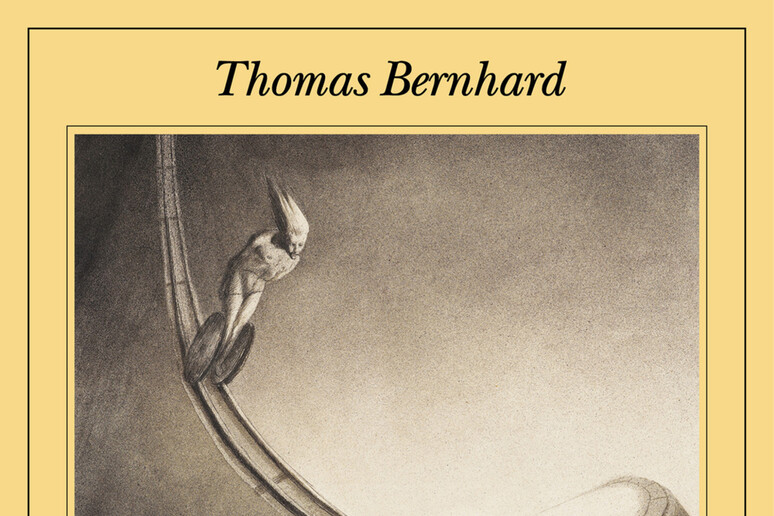(di Elisabetta Stefanelli)
THOMAS BERNHARD, 'CORREZIONE'
(Adelphi. Pag 290. Euro 20,00. Traduzione di Giovanna Agabio).
George Steiner ha definito Correzione il capolavoro di Thomas
Bernhard ma sinceramente per me è difficile dire che qualcuna
delle sue opere non sia un capolavoro, tessera del mosaico,
semplice capitolo di quell'opera mondo che è la sua intera
produzione, narrativa, poetica, teatrale in cui ricorrono
ossessivamente quanto sublimemente temi e situazioni. Anche qui,
in questo romanzo apparso per la prima volta nel 1975 ed ora
meritoriamente ripubblicato da Adelphi nella traduzione di
Giovanna Agabio, ci si immerge nel fil rouge delle sue
ossessioni quasi 'gnommero' gaddiano, che non sono poche le
similitudini tra questi due giganti della letteratura.
Nel suo inconfondibile stile, dove incontrare un punto è cosa
rara, ci si avviluppano la mente e le membra nella vicenda di
Roithamer e la sua soffitta (che poi non è sua ma di Holler) con
le pareti piene di formule e di scaffali di libri. Una sentenza
aveva destinato alla voce narrante - amico d'infanzia e
professore di matematica a Cambridge dove Roithamer insegnava
scienze naturali - le opere postume di quel genio folle che
aveva impiegato gli ultimi anni della sua vita a costruire in
tempi record e con metodi misteriosi, senza l'ausilio degli
odiati architetti, un cono, si un utopistico cono da abitare,
nel centro di un bosco in cui aveva investito tutti i milioni
ricevuti in eredità. Lo aveva fatto per donarlo alla sorella che
però era morta prima di lui lasciandolo a sua volta senza più
ragioni per vivere, tanto da portarlo al suicidio.
Ecco quindi il suicidio che torna, così come i sentimenti
contrastanti per l'Austria ("da un lato amava l'Austria che era
la sua origine ma nello stesso tempo la odiava perché per tutta
la vita gli aveva dato solo delle bastonate e ogni volta che ne
aveva avuto bisogno l'aveva respinto"), e per la scuola ("ogni
scuola che ho frequentato mi ha depresso ogni scuola che ho
frequentato, che ho dovuto frequentare, mi ha umiliato"). Ma il
tema centrale che qui ritorna è quello del confronto con il
genio. "Infatti mi chiedo con quale ordine di grandezza ho a che
fare quando mi occupo di Roithamer?", si chiede la voce
narrante. Sembra che il personaggio di Roithamer sia ispirato a
Ludwig Wittgenstein, che era altrettanto legato alla sorella ed
insegnava a Cambridge. Qui, come ad esempio ne Il soccombente
ispirato invece a Glenn Gould, c'è il dilemma e l'inesauribile
tormento di chi pratica una disciplina con ottimi risultati ma
si rende conto che in nessun caso potrà raggiungere il genio,
che pure a differenza di altri, comprende e ammira in una
infinita aspirazione tanto da seguirne le orme. Anche in
Correzione torna l'amore per la musica: Roithamer ama la musica
e suona il pianoforte e la considera uno strumento di
conoscenza. La Correzione del titolo è del resto l'essenza del
genio, il tendere ad una perfezione che consiste in una continua
correzione appunto. E quello che interessa a Bernhard è
estremo, la sua ricerca è estrema come estremi sono i suoi
personaggi il suo spingere letteralmente il lettore nella
spirale di una ripetitività ipnotica sul limite di un abisso
dove l'assoluto incontra il nulla. Sempre parco nell'uso dei
punti, perché è difficile concludere un pensiero, ingabbiare una
frase in un ritmo logico. E alla fine la natura, avviluppando
tutto, farà il suo corso.
Riproduzione riservata © Copyright ANSA